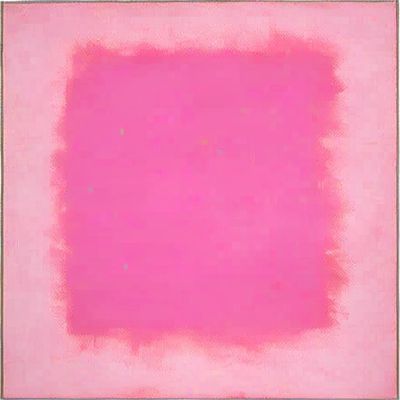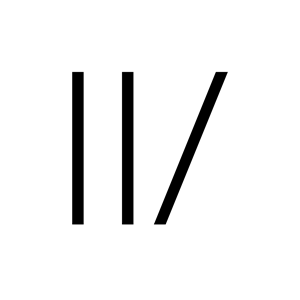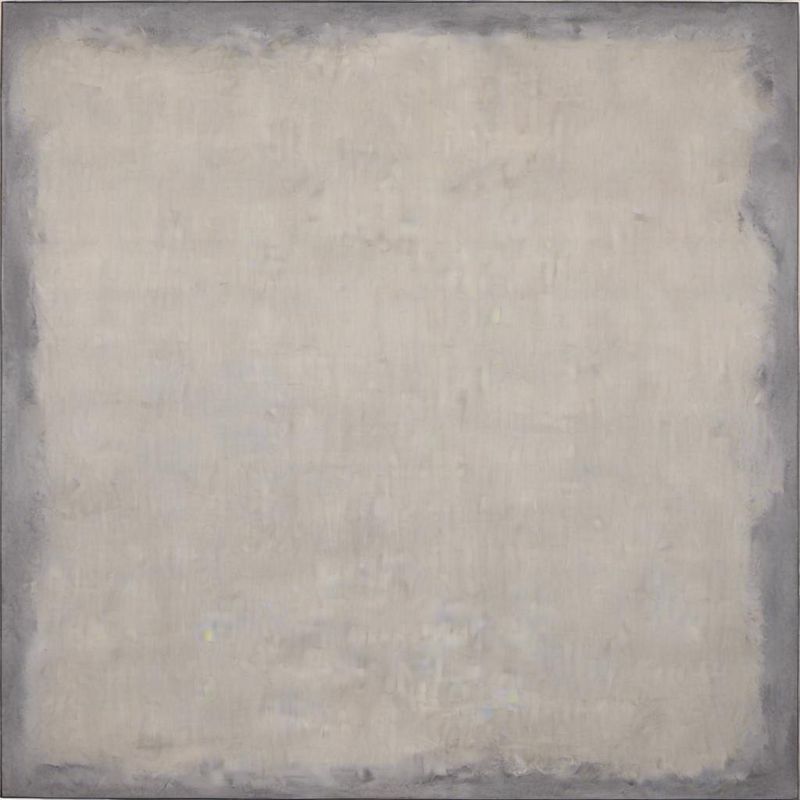Origine, evoluzione e linguaggio attorno al termine “autistico”
Il termine "autistico" porta con sé un peso di significati, interpretazioni e, purtroppo, spesso fraintendimenti che si sono stratificati nel corso dei decenni. Comprendere il vero significato di essere autistici significa intraprendere un viaggio attraverso la scienza, la cultura e l'esperienza umana, per arrivare a una comprensione più profonda e rispettosa di questa forma di neurodivergenza che caratterizza milioni di persone in tutto il mondo.
Quando parliamo di autismo, non stiamo descrivendo una malattia da curare o un deficit da correggere, ma piuttosto un modo diverso di essere, di percepire il mondo e di elaborare le informazioni.
Questa prospettiva, che ha guadagnato sempre più riconoscimento negli ultimi anni, rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui la società comprende e si relaziona con le persone autistiche.
Il significato di "autistico" si estende ben oltre le definizioni cliniche e diagnostiche, toccando aspetti identitari, culturali e sociali che influenzano profondamente la vita delle persone autistiche e delle loro famiglie. È un termine che racchiude diversità, complessità e una ricchezza di esperienze umane che meritano di essere comprese, rispettate e valorizzate.
Etimologia e evoluzione del termine
Le origini linguistiche
Il termine "autismo" deriva dal greco antico "αὐτός" (autos), che significa "se stesso". Questa radice etimologica fu utilizzata per la prima volta in ambito psichiatrico dal medico svizzero Eugen Bleuler nel 1911, che la impiegò per descrivere un sintomo della schizofrenia caratterizzato dal ritiro sociale e dall'autoreferenzialità.
L'uso originale del termine da parte di Bleuler si riferiva a una tendenza al ritiro dal mondo esterno e a una concentrazione eccessiva sui propri pensieri e fantasie.
Tuttavia, quando Leo Kanner nel 1943 descrisse quello che chiamò "autismo infantile precoce", il termine assunse un significato diverso e più specifico, riferendosi a un pattern distintivo di sviluppo e comportamento osservato nei bambini.
L'evoluzione semantica del termine riflette l'evoluzione della comprensione scientifica dell'autismo. Da una descrizione di sintomi isolati, il termine è cresciuto per abbracciare una comprensione più complessa e sfumata di una condizione neurologica che influenza molteplici aspetti del funzionamento umano.
Da autismo a disturbi dello spettro autistico
La transizione terminologica da "autismo" a "disturbi dello spettro autistico" rappresenta un cambiamento paradigmatico nella comprensione di questa condizione. Il concetto di "spettro" riconosce che l'autismo si manifesta in una vasta gamma di modi, con livelli diversi di supporto necessario e con una grande variabilità nelle capacità e nelle sfide individuali. Questa evoluzione terminologica riflette una comprensione più sofisticata della neurodiversità umana.
Piuttosto che vedere l'autismo come una condizione monolitica, il modello dello spettro riconosce che le persone autistiche possono avere profili molto diversi di punti di forza e sfide, richiedendo approcci individualizzati al supporto e all'intervento.
Il termine "spettro" ha anche contribuito a ridurre la stigmatizzazione, allontanandosi da concezioni rigide e spesso negative dell'autismo verso una comprensione più inclusiva e rispettosa della diversità neurologica.
Il movimento neurodivergente e il linguaggio
Il movimento neurodivergente ha profondamente influenzato il modo in cui parliamo di autismo e di essere autistici. Questo movimento, guidato principalmente da persone autistiche stesse, promuove l'uso di un linguaggio che rispetti l'identità e la dignità delle persone autistiche.
Una delle questioni linguistiche più significative riguarda l'uso di "persona autistica" versus "persona con autismo". Mentre il linguaggio "person-first" (persona con autismo) è stato tradizionalmente preferito in ambito clinico, molte persone autistiche preferiscono il linguaggio "identity-first" (persona autistica), vedendo l'autismo come parte integrante della loro identità piuttosto che come qualcosa che "hanno".
Questo dibattito linguistico riflette questioni più profonde sull'identità, l'appartenenza e il modo in cui la società concettualizza la disabilità e la neurodivergenza. Il rispetto per le preferenze linguistiche delle persone autistiche è diventato un aspetto importante dell'advocacy e dell'alleanza.
Definizione scientifica e clinica
Criteri diagnostici attuali
Secondo il DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edizione), i disturbi dello spettro autistico sono caratterizzati da due domini principali di sintomi. Il primo dominio riguarda i deficit persistenti nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale attraverso molteplici contesti, manifestandosi attraverso difficoltà nella reciprocità socio-emotiva, nei comportamenti comunicativi non verbali e nello sviluppo e mantenimento di relazioni appropriate al livello di sviluppo.
Il secondo dominio comprende pattern ristretti e ripetitivi di comportamento, interessi o attività, che possono manifestarsi attraverso movimenti motori, uso di oggetti o linguaggio stereotipato o ripetitivo; aderenza eccessiva a routine, pattern ritualizzati di comportamento verbale o non verbale; interessi altamente ristretti e fissi che sono anormali per intensità o focus; iper- o ipo-reattività agli stimoli sensoriali o interesse inusuale per aspetti sensoriali dell'ambiente.
Questi criteri devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo, causare compromissioni clinicamente significative nel funzionamento sociale, lavorativo o in altre aree importanti, e non essere meglio spiegati da disabilità intellettiva o ritardo globale dello sviluppo.
Livelli di supporto
Il DSM-5 introduce un sistema di specificatori che indica il livello di supporto necessario: "richiede supporto", "richiede supporto sostanziale" e "richiede supporto molto sostanziale". Questa classificazione riconosce che le persone autistiche hanno esigenze molto diverse e che il supporto deve essere individualizzato.
Il livello 1 ("richiede supporto") si riferisce a persone che, senza supporto, mostrano deficit nella comunicazione sociale che causano compromissioni evidenti, difficoltà nell'iniziare interazioni sociali e atipiche o fallimentari risposte alle aperture sociali degli altri. Possono mostrare interesse ridotto per le interazioni sociali.
I livelli 2 e 3 indicano esigenze di supporto progressivamente maggiori, con compromissioni più severe nella comunicazione sociale e pattern più rigidi di comportamento che interferiscono significativamente con il funzionamento in molteplici contesti.
Prevalenza e epidemiologia
Le stime attuali suggeriscono che l'autismo è evidenziato in circa 1 persona su 36-44, con una prevalenza che è aumentata significativamente negli ultimi decenni.
Questo aumento è attribuito principalmente a una maggiore consapevolezza, criteri diagnostici ampliati e migliori strumenti di identificazione piuttosto che a un reale aumento dell'incidenza.
L'autismo è diagnosticato più frequentemente nei maschi che nelle femmine, con un rapporto di circa 4:1. Tuttavia, questa disparità di genere è sempre più messa in discussione, con evidenze crescenti che suggeriscono che le femmine possono essere sottodiagnosticate a causa di presentazioni diverse e di bias diagnostici.
L'autismo è presente in tutte le popolazioni etniche e socioeconomiche, sebbene esistano disparità nell'accesso alla diagnosi e ai servizi che possono influenzare le statistiche di prevalenza in diversi gruppi demografici.
Neurobiologia dell'autismo
Sviluppo cerebrale e connettività
La ricerca neuroscientifica ha rivelato differenze significative nello sviluppo e nella struttura cerebrale delle persone autistiche. Durante i primi anni di vita, molte persone autistiche mostrano una crescita accelerata del volume cerebrale, seguita da una normalizzazione o addirittura da una riduzione relativa durante l'adolescenza e l'età adulta.
Le neuroimmagini hanno identificato differenze nella connettività cerebrale, con pattern di iperconnettività locale e ipoconnettività a lungo raggio. Questo significa che le connessioni all'interno di aree cerebrali specifiche possono essere più intense del normale, mentre le connessioni tra aree cerebrali distanti possono essere ridotte.
Queste differenze nella connettività possono spiegare molte delle caratteristiche cognitive associate all'autismo, come l'eccellente attenzione ai dettagli, la difficoltà nell'integrazione di informazioni da fonti multiple e le sfide nell'elaborazione di informazioni complesse che richiedono coordinazione tra diverse aree cerebrali.
Elaborazione sensoriale
Le differenze nell'elaborazione sensoriale sono una caratteristica comune dell'autismo, con molte persone autistiche che sperimentano iper- o iposensibilità a vari stimoli sensoriali.
Queste differenze possono riguardare tutti i sistemi sensoriali: vista, udito, tatto, gusto, olfatto, propriocezione e sistema vestibolare.
L'ipersensibilità può manifestarsi come sovrastimolazione da luci brillanti, suoni forti, texture specifiche o odori intensi. Al contrario, l'iposensibilità può portare a ricerca di stimoli sensoriali intensi o a difficoltà nel riconoscere stimoli sensoriali importanti.
Queste differenze sensoriali non sono semplicemente preferenze, ma riflettono differenze neurobiologiche reali nell'elaborazione delle informazioni sensoriali. Comprendere e accomodare queste differenze è fondamentale per creare ambienti supportivi per le persone autistiche.
Funzioni esecutive e cognizione
Le funzioni esecutive, che includono pianificazione, flessibilità cognitiva, controllo inibitorio e memoria di lavoro, possono essere influenzate nell'autismo. Tuttavia, il profilo delle funzioni esecutive nelle persone autistiche è complesso e variabile, con alcuni domini che possono essere compromessi mentre altri rimangono intatti o addirittura superiori.
La flessibilità cognitiva, ovvero la capacità di adattarsi a cambiamenti nelle regole o nelle situazioni, può essere particolarmente sfidante per molte persone autistiche. Questo può manifestarsi come difficoltà nell'adattarsi a cambiamenti di routine, nel passare da un'attività all'altra o nel considerare prospettive alternative.
Tuttavia, molte persone autistiche mostrano punti di forza in aree specifiche della cognizione, come l'attenzione ai dettagli, la memoria per fatti specifici e la capacità di riconoscere pattern. Questi punti di forza cognitivi possono essere significativi e dovrebbero essere riconosciuti e valorizzati.
Manifestazioni comportamentali e cognitive
Comunicazione e linguaggio
Le differenze nella comunicazione sono una caratteristica centrale dell'autismo, ma si manifestano in modi molto diversi tra le persone autistiche. Alcune persone possono avere difficoltà significative con il linguaggio parlato, mentre altre possono avere competenze linguistiche formali eccellenti ma difficoltà con gli aspetti pragmatici della comunicazione.
La pragmatica del linguaggio, ovvero l'uso sociale della comunicazione, può essere particolarmente sfidante.
Questo include la comprensione di segnali non verbali, l'uso appropriato del contatto visivo, la comprensione di ironia e sarcasmo, e la capacità di adattare lo stile comunicativo al contesto sociale.
Molte persone autistiche sviluppano modalità comunicative alternative o augmentative, inclusi sistemi di comunicazione assistita, linguaggio dei segni o comunicazione scritta. È importante riconoscere che la comunicazione non verbale non è meno valida o significativa della comunicazione verbale.
Interessi e attività
Gli interessi intensi e specifici sono una caratteristica comune dell'autismo e possono essere una fonte significativa di gioia, motivazione e competenza per le persone autistiche. Questi interessi possono variare enormemente, da argomenti accademici come la matematica o la scienza, a hobby come i treni o i videogiochi, a interessi creativi come l'arte o la musica.
L'intensità di questi interessi può essere straordinaria, portando le persone autistiche a sviluppare conoscenze enciclopediche nei loro campi di interesse. Questa passione e dedizione può tradursi in competenze eccezionali e contributi significativi in vari ambiti.
È importante distinguere tra interessi autistici funzionali e comportamenti ripetitivi che possono causare distress. Mentre gli interessi intensi sono generalmente positivi e dovrebbero essere supportati, alcuni comportamenti ripetitivi possono richiedere intervento se interferiscono significativamente con il funzionamento quotidiano.
Routine e prevedibilità
La preferenza per routine e prevedibilità è comune nelle persone autistiche e serve spesso una funzione importante nella gestione dell'ansia e nella creazione di un senso di sicurezza e controllo. Le routine possono riguardare attività quotidiane, percorsi specifici, ordini di eventi o modi particolari di organizzare l'ambiente.
I cambiamenti imprevisti nelle routine possono essere particolarmente stressanti per molte persone autistiche, portando ad ansia, distress o comportamenti di coping.
Tuttavia, con supporto appropriato e preparazione graduale, molte persone autistiche possono imparare a gestire i cambiamenti in modo più flessibile.
È importante bilanciare il rispetto per il bisogno di routine con l'incoraggiamento di una flessibilità appropriata. Le routine non dovrebbero essere viste come rigidità patologica, ma piuttosto come strategie adattive che possono essere gradualmente espanse e modificate secondo necessità.
Diversità all'interno dello spettro
Autismo e disabilità intellettiva
Contrariamente a stereotipi comuni, l'autismo può presentarsi con qualsiasi livello di capacità intellettiva. Mentre alcune persone autistiche hanno disabilità intellettive concomitanti, molte altre hanno intelligenza nella norma o superiore alla media.
Questa diversità cognitiva all'interno dello spettro autistico è importante da riconoscere e comprendere.
Le persone autistiche con disabilità intellettive possono richiedere supporti più intensivi in molte aree della vita, ma mantengono la loro dignità, i loro diritti e il loro potenziale di crescita e sviluppo. È importante non sottovalutare le capacità di queste persone o limitare le loro opportunità basandosi su assunzioni sui loro limiti.
D'altra parte, le persone autistiche con intelligenza nella norma o superiore possono affrontare sfide uniche, incluse aspettative irrealistiche, mancanza di supporto appropriato e difficoltà nell'ottenere riconoscimento per le loro esigenze di supporto.
Autismo "ad alto funzionamento" e "a basso funzionamento"
I termini "alto funzionamento" e "basso funzionamento" sono spesso utilizzati per descrivere persone autistiche, ma sono sempre più criticati dalla comunità autistica e dai ricercatori. Questi termini sono problematici perché riducono la complessità dell'esperienza autistica a una singola dimensione e possono portare a fraintendimenti e discriminazione.
Una persona descritta come "ad alto funzionamento" può eccellere in alcune aree ma avere significative difficoltà in altre. Allo stesso modo, una persona descritta come "a basso funzionamento" può avere capacità e punti di forza che non sono immediatamente evidenti o riconosciuti.
È più utile e rispettoso descrivere le specifiche esigenze di supporto di una persona in diverse aree della vita, piuttosto che utilizzare etichette globali che possono essere fuorvianti e stigmatizzanti.
Masking e Camouflaging
Il masking o camouflaging si riferisce alla pratica di nascondere o sopprimere tratti autistici per apparire più "neurotipici" in situazioni sociali. Questo comportamento è particolarmente comune nelle donne e ragazze autistiche, ma può essere presente in persone autistiche di tutti i generi.
Il masking può includere l'imitazione di comportamenti sociali osservati, la soppressione di stimming (comportamenti autoregolatori), il forcing del contatto visivo e la creazione di "script" sociali per navigare le interazioni.
Mentre può facilitare l'accettazione sociale, il masking può essere emotivamente e fisicamente esaustivo.
Il riconoscimento del masking è importante per comprendere che alcune persone autistiche possono non mostrare tratti autistici evidenti in superficie, ma possono comunque sperimentare le sfide interne associate all'autismo. Questo ha implicazioni importanti per la diagnosi, il supporto e la comprensione dell'esperienza autistica.
Autismo e identità
Autismo come neurodivergenza
Il movimento della neurodivergenza ha rivoluzionato il modo in cui molte persone autistiche vedono se stesse e la loro condizione. Piuttosto che vedere l'autismo come un disturbo da curare, questo movimento promuove la comprensione dell'autismo come una variazione naturale della neurodiversità umana.
Questa prospettiva enfatizza i punti di forza e i contributi unici che le persone autistiche possono portare alla società, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sui deficit e sulle sfide. Riconosce che le differenze neurologiche possono portare a modi diversi ma ugualmente validi di percepire, elaborare e interagire con il mondo.
Il paradigma della neurodivergenza ha profonde implicazioni per come la società dovrebbe supportare le persone autistiche, spostando l'enfasi dall'adattamento forzato alla creazione di ambienti più inclusivi e accessibili.
Cultura autistica
La crescente connettività globale e le comunità online hanno facilitato lo sviluppo di una cultura autistica distintiva. Questa cultura include linguaggi condivisi, valori, tradizioni e modi di essere che sono specifici della comunità autistica.
Elementi della cultura autistica possono includere l'apprezzamento per la comunicazione diretta e onesta, il valore posto sugli interessi intensi, l'accettazione di comportamenti stimming e la celebrazione delle differenze sensoriali e cognitive. Questa cultura fornisce un senso di appartenenza e identità per molte persone autistiche.
La cultura autistica sfida anche molte norme sociali neurotipiche, proponendo modi alternativi di interagire, comunicare e essere in relazione che possono essere più autentici e confortevoli per le persone autistiche.
Intersezionalità e identità multiple
È importante riconoscere che l'identità autistica interseca con altre identità, incluse quelle di genere, razza, etnia, orientamento sessuale, classe socioeconomica e altre caratteristiche. Queste identità multiple possono creare esperienze uniche e complesse che devono essere comprese e rispettate.
Per esempio, le donne autistiche possono affrontare sfide specifiche legate sia al genere che all'autismo, mentre le persone autistiche di colore possono sperimentare forme multiple di discriminazione e barriere all'accesso ai servizi.
Il riconoscimento dell'intersezionalità è fondamentale per sviluppare supporti e servizi che siano veramente inclusivi e che rispondano alle diverse esigenze della comunità autistica.
Sfide e stereotipi comuni
Miti sull'autismo
Numerosi miti e misconcezioni sull'autismo persistono nella società, spesso alimentati da rappresentazioni inaccurate nei media e da informazioni obsolete. Uno dei miti più dannosi è che le persone autistiche manchino di empatia. In realtà, molte persone autistiche sono profondamente empatiche, ma possono esprimere l'empatia in modi diversi o avere difficoltà nel riconoscere i segnali emotivi degli altri.
Un altro mito comune è che tutte le persone autistiche abbiano abilità savant o talenti eccezionali. Mentre alcune persone autistiche hanno infatti abilità straordinarie in aree specifiche, questo non è universale e può creare aspettative irrealistiche.
Il mito che l'autismo sia causato da vaccini è stato completamente smentito dalla ricerca scientifica, ma continua a persistere e può portare a decisioni dannose per la salute pubblica.
Rappresentazioni nei media
Le rappresentazioni dell'autismo nei media hanno spesso perpetuato stereotipi e fraintendimenti. Molte rappresentazioni si concentrano su personaggi maschili con abilità eccezionali ma significative difficoltà sociali, creando un'immagine limitata e spesso inaccurata dell'autismo.
Queste rappresentazioni possono influenzare le aspettative del pubblico e rendere più difficile per le persone autistiche che non si conformano a questi stereotipi ottenere comprensione e supporto. È importante promuovere rappresentazioni più diverse e accurate dell'autismo nei media.
La crescente partecipazione di attori autistici e consulenti autistici nella produzione di contenuti mediatici sta contribuendo a rappresentazioni più autentiche e rispettose.
Discriminazione e stigma
Nonostante i progressi nella comprensione dell'autismo, le persone autistiche continuano ad affrontare discriminazione e stigma in molti ambiti della vita. Questo può includere discriminazione nell'istruzione, nell'impiego, nell'assistenza sanitaria e nelle relazioni sociali.
La discriminazione può essere esplicita, come il rifiuto di assumere una persona a causa del suo autismo, o più sottile, come aspettative ridotte o trattamento paternalistico. Entrambe le forme di discriminazione possono avere effetti dannosi sulla qualità della vita e sulle opportunità delle persone autistiche.
La lotta contro la discriminazione richiede sforzi continui nell'educazione, nella sensibilizzazione e nello sviluppo di politiche e pratiche più inclusive.
Supporto e inclusione
Principi di supporto efficace
Il supporto efficace per le persone autistiche dovrebbe essere basato su principi di rispetto, individualizzazione e empowerment. Questo significa riconoscere che ogni persona autistica è unica, con i propri punti di forza, sfide, preferenze e obiettivi.
Il supporto dovrebbe essere centrato sulla persona, coinvolgendo attivamente la persona autistica nelle decisioni che la riguardano. Dovrebbe anche essere basato sui punti di forza, costruendo sulle capacità e gli interessi esistenti piuttosto che concentrarsi esclusivamente sui deficit.
È importante che il supporto sia culturalmente sensibile e rispetti l'identità autistica, piuttosto che cercare di "normalizzare" o eliminare tratti autistici che sono parte integrante dell'identità della persona.
Ambienti inclusivi
La creazione di ambienti inclusivi richiede modifiche fisiche, sociali e culturali che rendano gli spazi più accessibili e accoglienti per le persone autistiche. Questo può includere considerazioni sensoriali come l'illuminazione, il rumore e la texture, così come modifiche sociali come comunicazione chiara e aspettative esplicite.
Gli ambienti inclusivi dovrebbero anche valorizzare la neurodiversità e celebrare le differenze piuttosto che richiedere conformità a norme neurotipiche. Questo crea spazi dove le persone autistiche possono essere autentiche e confortevoli.
L'inclusione non è solo una questione di accomodamenti fisici, ma richiede anche cambiamenti di atteggiamento e cultura che promuovano l'accettazione e la valorizzazione delle differenze.
Advocacy e autodeterminazione
L'advocacy, sia da parte delle persone autistiche stesse che da parte di alleati, è fondamentale per promuovere i diritti e il benessere delle persone autistiche.
L'autodeterminazione, ovvero il diritto delle persone autistiche di prendere decisioni sulla propria vita, è un principio centrale dell'advocacy moderna.
Questo include il diritto di scegliere dove vivere, con chi associarsi, che tipo di supportoricevere e come esprimere la propria identità autistica. L'advocacy lavora per rimuovere le barriere che impediscono l'autodeterminazione e per promuovere politiche e pratiche che supportano l'autonomia e la dignità.
Il movimento "Nothing about us, without us" (Niente su di noi, senza di noi) sottolinea l'importanza di includere le voci delle persone autistiche in tutte le decisioni e politiche che le riguardano.
Prospettive future
Ricerca e innovazione
La ricerca sull'autismo continua a evolversi, con nuovi approcci che enfatizzano la partecipazione delle persone autistiche come co-ricercatori piuttosto che solo come soggetti di studio. Questa ricerca partecipativa sta producendo intuizioni più rilevanti e utili per la comunità autistica.
Le innovazioni tecnologiche stanno aprendo nuove possibilità di supporto, dalla realtà virtuale per l'allenamento delle abilità sociali alle app per la comunicazione e la gestione sensoriale.
Tuttavia, è importante che queste tecnologie siano sviluppate con e per le persone autistiche, non semplicemente su di loro.
La ricerca futura dovrebbe continuare a esplorare la diversità all'interno dello spettro autistico e sviluppare approcci di supporto più personalizzati e efficaci.
Cambiamenti sociali
La crescente consapevolezza e accettazione dell'autismo nella società sta portando a cambiamenti positivi in molti settori. Le scuole stanno diventando più inclusive, i datori di lavoro stanno riconoscendo il valore della neurodiversità, e i servizi sanitari stanno migliorando la loro comprensione dell'autismo.
Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare per creare una società veramente inclusiva. Questo richiede sforzi continui nell'educazione, nella sensibilizzazione e nello sviluppo di politiche che supportino i diritti e il benessere delle persone autistiche.
Il movimento della neurodiversità continuerà probabilmente a influenzare questi cambiamenti, promuovendo una comprensione dell'autismo come differenza piuttosto che deficit.
Visione per il futuro
La visione per il futuro è quella di una società dove le persone autistiche sono valorizzate per i loro contributi unici, dove hanno accesso a supporti appropriati quando necessario, e dove possono vivere vite autodeterminate e soddisfacenti.
Questo futuro richiede un cambiamento fondamentale nel modo in cui la società vede e si relaziona con la neurodiversità. Significa passare da un modello medico che si concentra sui deficit a un modello sociale che riconosce le barriere ambientali e culturali.
Significa anche riconoscere che l'autismo è una parte permanente e preziosa della diversità umana, e che le persone autistiche hanno il diritto di essere rispettate, incluse e valorizzate per chi sono.
Continua la lettura
Potrebbe piacerti anche
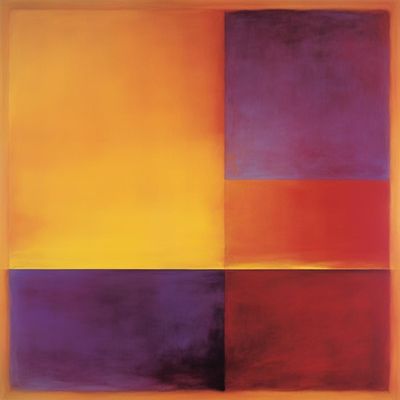
Meltdown, Shutdown e Tantrum: cosa sapere sulle crisi autistiche

Neurodivergenze e benessere integrato: il ruolo dell’alimentazione anti-infiammatoria

Asperger: dalla scoperta storica alla comprensione moderna dell’autismo

Autismo e disturbi di personalità: guida pratica per comprenderli e offrire supporto efficace